Pubblichiamo l’inchiesta vincitrice del Premio Mani Tese per il Giornalismo Investigativo e Sociale 2020 che aveva come obiettivo il sostegno alla produzione di inchieste originali su tematiche concernenti gli impatti dell’attività di impresa sui diritti umani e sull’ambiente. L’edizione 2020 del premio è stata realizzata nell’ambito del progetto “Cambia Moda” con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) all’interno del programma MADE IN JUSTICE di Mani Tese.
di MARTINA DI PIRRO e MAGED SROUR
Illustrazioni di FRANCESCA FERRARA
1. La "droga pulita" all'ombra del vesuvio
C’è odore di terra bagnata e spazzatura. Il Vesuvio sovrasta prepotente la luce del sole al tramonto, che illumina a fatica tredici capannoni abbandonati nell’hinterland di Pompei, sottoposti a sequestro dal 2018. Circa 6mila tonnellate di rifiuti speciali, tra indumenti usati, accessori per l’abbigliamento, pezzami da lavorazione e scarti tessili, sbucano dalle fessure dei portoni semiaperti.
Il sequestro è stato solo il punto di inizio. Da quel giorno, sono partite una serie di attività investigative condotte dai finanzieri del gruppo di Torre Annunziata e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. E, a luglio del 2020, nell’ambito dell’operazione ‘Hercules’, è stato accertato un traffico illecito di rifiuti nel territorio di Napoli, Melito di Napoli, Boscotrecase, Terzigno, Pompei e Castellammare di Stabia: 12mila tonnellate di rifiuti accatastati in capannoni sparsi nelle campagne del territorio. Alla luce del sole. Tra case, autofficine e campi di cicoria.



Un’ordinanza emessa dalla procura nei confronti di 17 persone – una delle quali finita in carcere, dieci ai domiciliari e sei raggiunte dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – che porta con sé un’accusa precisa: organizzazione criminale dedita alla realizzazione di un ingente traffico illecito di rifiuti speciali. Uno smaltimento non solo illegale ma anche effettuato senza rispettare le procedure previste dalla normativa ambientale. Dal quadro indiziario elaborato dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata emerge la sussistenza di una sistematica raccolta e movimentazione di rifiuti, provenienti da aziende di tessuti e abbigliamento e operanti nel settore del relativo trattamento e smaltimento.

La dinamica è semplice: le oltre 12mila tonnellate di rifiuti speciali, grazie al coinvolgimento di autotrasportatori, vengono stoccate illecitamente in enormi capannoni presi in affitto da ignari proprietari (ai quali il sodalizio talvolta non corrisponde neppure il pattuito canone di locazione) e che, una volta completamente riempiti, vengono abbandonati. Un modus operandi che si ripete ogni volta che la criminalità organizzata mette le mani nel settore degli abiti di seconda mano. Per capire gli interessi che può muovere il tema degli abiti usati, basta pensare che, secondo la fondazione antimafia Caponnetto, ogni anno si raccolgono 110mila tonnellate di abiti in Italia, una media di 1,8 chili per abitante. Il Capitano Giuliano Ciotta, che ha guidato l’operazione dei finanzieri del nucleo di Torre Annunziata, conferma un punto essenziale: gli indumenti usati fanno parte di un settore estremamente redditizio, in grado, a volte, di portare maggiori profitti del traffico di droga. La “droga pulita”, così viene definita in alcune intercettazioni ambientali. E su questo traffico, fatto di zone d’ombra e faccendieri, sta facendo luce l’operazione della Dda di Napoli e il nucleo di Torre Annunziata.
Un modus operandi che si ripete. A dicembre 2020, la Guardia di Finanza di Nola ha sequestrato 46 tonnellate di vestiti, scarpe ed altro materiale vario, ancora conservato nei sacchetti per rifiuti, dichiarati “oggetti da rigattiere”, trovati su alcuni camion provenienti dalla Svizzera, senza il rispetto delle norme che disciplinano il traffico dei rifiuti.
Operazioni che hanno dei precedenti. Nel 2011 la Dda di Firenze aveva eseguito un centinaio di arresti nella zona di Prato. Il motivo era un traffico illecito di indumenti usati, arrivati dalla raccolta effettuata in territorio campano. Nell’operazione della Dda di Firenze era finito anche il presidente del Consorzio abiti usati (Conau), friulano di origini e residente a Treviso, e anche presidente e proprietario al 50 per cento dell’azienda T. SpA, leader nella commercializzazione degli indumenti usati, e attiva sin dal 1980. Durante un’audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle Ecomafie, Andrea Fluttero, attuale Presidente del CONAU, ha affermato che, a seguito delle indagini, il titolare della T. SpA, condannato per traffico illecito di rifiuti in primo grado, si è appellato alla sentenza e si è dimesso dal ruolo di Presidente, rimanendo nel Consorzio come socio.
Per lungo tempo ritenuta la prima azienda in Italia, la T. collaborò con le diverse Caritas diocesane del territorio per la raccolta di indumenti usati e con le cooperative parte del circuito Caritas. Nel 2017, l’operazione della Dda di Firenze ordinò un sequestro dei locali della T. a cui seguì una condanna in primo grado nel 2018 per il reato di traffico illecito di rifiuti. Le autorità competenti verificarono irregolarità nelle fasi di trasporto e trattamento di alcuni carichi di indumenti usati. La T., che nel 2018 aveva fatturato più di 12 milioni di euro, da sola trattava circa un terzo di tutti gli abiti raccolti in Italia. Un dato rilevante che però può far pensare ad un reale collegamento tra la T. SpA e la criminalità organizzata, erano i rapporti con il partner commerciale denominato Eurotrading International srl, azienda sequestrata e poi liquidata, guidata da Ciro Ascione, figlio di Vincenzo Ascione detto “Babbalaccone”, boss egemone ad Ercolano, ritenuto dagli inquirenti il referente in Toscana del clan di camorra Birra-Iacomino.
Insomma, fili collegati l’uno con l’altro, difficili da districare e però uniti dal commercio degli abiti usati. Ad oggi, Ciro Ascione è a capo della AVC International, una ditta impegnata nella lavorazione e nella raccolta di stracci e indumenti usati. Vincenzo Ascione è invece latitante in Tunisia. La T. continua ad operare ma non ha più rapporti con le cooperative legate al circuito Caritas e con le Caritas diocesane.
Come spiegava anche la Direzione Nazionale Antimafia già nel 2014 nella sua relazione annuale, «buona parte delle donazioni di indumenti usati che i cittadini fanno per solidarietà finiscono per alimentare un traffico illecito dal quale camorristi e sodali di camorristi traggono enormi profitti». La maggior parte degli abiti usati, infilati per solidarietà nei cassonetti delle città italiane, può finire in mano alla criminalità organizzata, che si approfitta delle cooperative per la raccolta e delle imprese incaricate di gestirla, a volte trasformate in vere e proprie case di spedizione specializzate in export illegale.
Le 12mila tonnellate ammassate in capannoni nel casertano e la vicenda T. servono allora da apripista per capire il ruolo della criminalità organizzata, soprattutto della camorra, all’interno della filiera degli abiti usati. Un business milionario che fa gola a molti. Una droga pulita, che porta grandi profitti. L’importante è trovare la falla nella filiera dell’abito, trovare la zona grigia in un settore legale ma poco trasparente. Molte inchieste della magistratura hanno messo in evidenza il legame tra criminalità organizzata e il settore dell’usato. I clan coinvolti, soprattutto i clan Birra-Iacomino e Ascione, sono sopravvissuti, in un modo o nell’altro, a quasi tutte le indagini a loro carico.
2. Il ruolo della criminalita' organizzata e il lavoro della commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie
«La raccolta degli abiti spesso è gestita da cooperative sociali a sfondo benefico - racconta Stefano Vignaroli, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Ecomafie dal 2018 - attraverso cassonetti stradali che in più di un caso riportano il logo della Caritas. Gli indumenti usati raramente vanno ai poveri: quasi sempre vengono venduti e i proventi non sempre sono usati a fini benefici». In una relazione inviata alla Commissione, il Procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho cita alcune importanti inchieste svolte dai magistrati delle Direzioni distrettuali a Roma, Milano, Potenza. «Esistono due poli principali della filiera degli abiti usati in Italia» continua Vignaroli «Uno è Prato, l’altro è la Campania, terra di origine delle famiglie camorristiche che tengono sotto scacco il settore». Una faccenda alquanto risaputa: nel 2012, di fronte ai parlamentari della Commissione Antimafia, il magistrato Ettore Squillace Greco affermava «I campani sanno bene che ad Ercolano non si vendono stracci se non si è legati ai Birra-Iacomino».
3. Dovete avere rapporti con la camorra
Il fatto che esistano infiltrazioni camorristiche all’interno delle cooperative operanti nel settore degli abiti usati è testimoniato anche da numerose inchieste giornalistiche. Da ultima, quella delle Iene, andata in onda nell’ottobre 2019.
E il fatto che il business sia oro per la camorra non è più un segreto. Una fonte anonima, ex operatore di una cooperativa sociale attiva nella raccolta di indumenti usati nel territorio romano, denuncia il complesso e ambiguo mondo delle cooperative e va oltre a quanto raccontato fino ad ora da tutte le inchieste. Secondo la fonte, lavorare all’interno di una di queste cooperative significa avere ben chiaro la spartizione del territorio. La fonte spiega che la cooperativa di cui faceva parte effettuava la raccolta svuotando i cassonetti ubicati sul territorio per il quale aveva l'incarico di raccolta. Il contenuto veniva poi portato in una R13 (Messa in Riserva al fine del Recupero), un magazzino autorizzato a stoccare i rifiuti tessili.
Dopo la raccolta e il trasporto nelle R13, per arrivare alla “conversione” da rifiuto a bene, intervengono delle aziende private che si occupano di compravendita di abiti usati.
La fonte fa poi riferimento ad assunzioni di soggetti svantaggiati provenienti proprio dai clan camorristi, ad un ruolo egemone di Caritas (senza specificare quale Caritas) nel posizionamento del logo, e la capacità di alcuni soggetti a capo delle cooperative di muoversi in amministrazioni di diverso colore politico aggirando i bandi delle pubbliche amministrazioni. La fonte conclude ricordando che, per molti operatori, i rapporti con la camorra sono cosa nota e ancor più nota è la relazione tra gli affiliati, alcune cooperative ed enti di beneficenza.
4. Il ruolo della caritas: un po' di chiarezza
In numerose audizioni parlamentari effettuate di fronte alla Commissione d’inchiesta, il nome della Caritas, noto ente religioso, compare più volte, direttamente ed indirettamente. Questo perché si tratta dell’ente di riferimento in Italia per la raccolta degli abiti usati. Gli indumenti depositati nei cassonetti con il logo Caritas, vengono infatti periodicamente raccolti da cooperative sociali legate al circuito della Caritas per poi essere sottoposti ad una prima selezione. I tessuti non riutilizzabili vengono acquistati da aziende che li trasformano in filati con i quali vengono poi realizzati nuovi vestiti. Gli indumenti in buono stato, invece, vengono mandati ad aziende specializzate che si occupano dell’igienizzazione, selezione e invio a mercati di terzo livello (soprattutto in Africa) per essere rivenduti.
In questi anni, però, il nome della Caritas, e delle cooperative annesse, è stato talvolta associato alle numerose indagini delle autorità ed è stato al centro di alcune inchieste giornalistiche. Così come la fonte anonima, anche altri hanno accusato l’ente di aver avuto rapporti con soggetti legati alla criminalità organizzata.



Fonte: www.caritasambrosiana.it
Prima di ascoltare quanto dichiarato da Caritas ai microfoni di questa inchiesta, e per rigore giornalistico, è doverosa una premessa. Il primo anello di confusione si incontra proprio nell’utilizzo generico ed inesatto del nome “Caritas”. La Caritas è un organismo ecclesiale territoriale. Ogni Caritas diocesana è autonoma per organizzazione, gestione dei bilanci e risponde in ultima istanza al proprio vescovo. Caritas Italiana ha il compito di coordinare le singole Caritas Diocesane ma è improprio parlare di un soggetto unico con il nome Caritas che agisce su tutto il territorio nazionale nello stesso modo.
Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana, e quindi dell’organismo ecclesiale della Diocesi di Milano che opera nei territori di Milano, Monza, Lecco, Varese e le rispettive province, ha risposto ad alcune domande che aiutano a chiarire i passaggi chiave.
D: Direttore, qual è solitamente la filiera degli abiti usati che finiscono nei cassonetti gialli con il logo Caritas?
R: Occorre fare una distinzione tra i cassonetti per la raccolta degli indumenti posti presso le parrocchie e i cassonetti posizionati sul suolo pubblico, previa autorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni. I cassonetti posizionati presso le parrocchie servono ad alimentare i centri di distribuzione parrocchiali: in questo caso gli abiti che vengono conferiti sono consegnati direttamente alle persone in difficoltà. Tuttavia, poiché la quantità di abiti di cui i cittadini decidono ogni anno di fare a meno è molto superiore alle richieste di vestiti espresse dalle persone in difficoltà, Caritas Ambrosiana ha promosso una seconda rete di raccolta, tramite appunto i cassonetti gialli posizionati su suolo pubblico. Questa raccolta è affidata a cooperative sociali allo scopo di dare lavoro a persone svantaggiate, estrarre valore dagli indumenti raccolti e trasformare tale valore in progetti sociali a vantaggio di soggetti deboli che vivono sul territorio in cui Caritas Ambrosiana opera. Quindi, tutti gli abiti e gli accessori che sono raccolti tramite i cassonetti sul suolo pubblico sono commercializzati dalle stesse cooperative che gestiscono il servizio affidato loro tramite bando alle pubbliche amministrazioni. Quanto le cooperative ricavano dalla vendita, al netto dei costi di gestione e degli investimenti necessari, viene utilizzato per finanziare progetti sociali promossi da Caritas Ambrosiana. Caritas Ambrosiana, quindi, NON ha alcun ruolo operativo né commerciale, ma garantisce che il valore ricavato da tale attività commerciale venga impiegato per finalità sociali. Il logo sul cassonetto testimonia la vicinanza e il supporto della Caritas Ambrosiana alla Cooperativa che svolge il servizio ed attesta il fatto che i proventi della raccolta sono utilizzati sul territorio diocesano per sostenere progetti di solidarietà condivisi o promossi da Caritas Ambrosiana.
D:Qual è il rapporto tra Caritas e le cooperative che gestiscono il contenuto dei cassonetti?
R: C’è un rapporto di condivisione e collaborazione. Caritas Ambrosiana verifica che le finalità occupazionali, solidaristiche ed educative del progetto siano garantite ma non partecipa alla gestione operativa del progetto né agli scambi commerciali relativi alla vendita del materiale raccolto attraverso i cassonetti. Lo scambio informativo è costante ma la gestione tecnico/operativa ed imprenditoriale è totalmente in capo alle cooperative sociali. E quindi sono le cooperative ad avere rapporti commerciali con le aziende del settore. Per quanto riguarda invece i controlli, Caritas Ambrosiana si accerta che le cooperative facciano tutto quello che un soggetto privato, come sono appunto le cooperative, può svolgere per assicurarsi la piena legittimità del proprio operato: certificazioni, autorizzazioni, protocolli. La storia di questi 22 anni ha dimostrato che NESSUNA cooperativa sul territorio della Diocesi di Milano ha commesso illeciti amministrativi né tanto meno penali e tutte le indagini hanno dimostrato la piena legittimità dell’operato delle cooperative.
D: La filiera degli abiti così come descritta, Le pare una filiera trasparente? Non soggetta quindi a nessun tipo di infiltrazione?
R: Da anni denunciamo alle autorità i limiti di questa filiera: la mancanza di adeguati impianti in Italia, l’assenza di un sostegno pubblico a questa raccolta differenziata e la grande dipendenza da impianti esteri per il trattamento di buona parte del materiale raccolto e selezionato in Italia. Da rappresentanti delle istituzioni ci aspetteremmo delle risposte su questi temi. Sarebbe bene anche che su questi argomenti si iniziasse a sensibilizzare sia l’opinione pubblica che le amministrazioni pubbliche, affinché possano essere trovate delle soluzioni. Non c’è più molto tempo visto che a partire da gennaio del 2022 la raccolta differenziata del rifiuto tessile sarà un obbligo di legge.
D: Durante un’audizione presso la Commissione di Inchiesta sulle Ecomafie, Caritas Italiana ha affermato che il controllo del logo è molto difficile ma che stava migliorando questa parte di gestione. Come si muove invece Caritas Ambrosiana sul punto?
R: Caritas Ambrosiana concede l’utilizzo del logo a cooperative sociali che rispettano precisi standard almeno dal 1998. Dal 2012 con la costituzione della Rete R.I.U.S.E gli standard qualitativi del servizio sono notevolmente aumentati rafforzando l’operato delle cooperative che operano la raccolta.
La Rete R.I.U.S.E. (Raccolta Indumenti Usati Solidale ed Etica) a cui fa riferimento Gualzetti, raccoglie le cooperative legate al mondo Caritas che gestiscono i cassonetti gialli per la raccolta degli indumenti usati finalizzata al riutilizzo nella diocesi di Milano, Brescia e Bergamo. Secondo i dati pubblici, aggiornati al 2019, la Rete R.I.U.S.E gestisce direttamente la raccolta con 2.076 cassonetti stradali, occupa stabilmente 89 lavoratori di cui 29 soggetti svantaggiati, recupera circa 12.170 tonnellate di indumenti usati senza alcun costo per la collettività, destina importanti risorse a progetti di solidarietà sul territorio delle due Diocesi (nel 2019 €456.059 in Diocesi di Milano e €104.947 in Diocesi di Brescia). Dal 1998 al 2018 ha garantito contributi a progetti di solidarietà per circa 4 milioni di euro.

Eppure, Stefano Vignaroli, facendo riferimento ad un’azienda, la Nuova Tessil Pezzame sas ed al suo titolare Carmine Scarano, oggetto di un’indagine della magistratura dalla quale emersero irregolarità nella gestione degli indumenti usati che non sarebbero stati sottoposti ad igienizzazione prima della loro commercializzazione come beni usati, afferma «Carmine Scarano della Nuova Tessil Pezzame è stato arrestato per illeciti ambientali. Dalle intercettazioni trascritte nell’ordinanza di arresto risultava chiaro quanto fosse forte il legame tra Scarano e il Direttore della Rete R.I.U.S.E. Carmine Guanci. Inoltre, la società T. e tutti i suoi soci sono stati condannati in primo grado per i medesimi illeciti ambientali, a culmine di un processo iniziato nel 2011. Nel febbraio 2017 i soci di T. erano stati rinviati a giudizio per associazione a delinquere con il camorrista Vincenzo Ascione».
5. Il ruolo delle cooperative
Per capire meglio il ruolo delle cooperative e perché sia così sottile la linea tra chi opera per la solidarietà e chi no, è utile partire dall’affermazione del Presidente Vignaroli. Nel novembre 2017 la società Nuova Tessil Pezzame sas ed il suo titolare Carmine Scarano sono stati oggetto di un’indagine della magistratura coordinata dalla Dda di Milano, che ha condotto agli arresti Scarano e Guglielmo Giusti, vice presidente della Onlus L'Africa nel Cuore. I due posizionavano i cassonetti per la raccolta dei vestiti usati, con il marchio della Onlus L'Africa nel Cuore. Tali cassonetti risultavano, per il 95%, irregolari, ovvero posizionati in assenza della necessaria convenzione con il Comune.
Secondo la ricostruzione del Gip, il 68% degli abiti dichiarati in entrata alla Nuova Tessil Pezzame proveniva dalla cooperativa “Vesti Solidale”, cooperativa facente parte della Rete R.I.U.S.E.
Carmine Guanci, direttore della Rete R.I.U.S.E, e Matteo Lovatti, Presidente del CdA di Vesti Solidale, hanno accettato di rispondere ad alcune domande per chiarire finalmente alcuni punti essenziali.
D: Di cosa si occupa Vesti Solidale? Vesti Solidale fa parte della Rete R.I.U.S.E?
R: Vesti Solidale è una Cooperativa Sociale di tipo B promossa da Caritas Ambrosiana. Dal 1998 opera nel settore ambientale al fine di creare occupazione per fasce deboli di popolazione e promuovere percorsi di emancipazione che passino attraverso servizi utili per la collettività e tutelanti per l’ambiente in cui viviamo. Facciamo parte della rete R.I.U.S.E dal 2012, anno in cui è nata.
D: Gli abiti raccolti da Vesti Solidale che percorso fanno? A quali aziende vengono dati? In quale percentuale?
R:Gli abiti raccolti da Vesti Solidale vengono in piccola parte selezionati per essere avviati a riuso. La gran parte degli abiti raccolti è venduta ad aziende autorizzate alla selezione, cernita e commercializzazione sia in Italia che all’estero secondo la normativa ambientale e fiscale italiana. Per quanto riguarda il nome delle aziende non riteniamo di fornire tale indicazione per motivi commerciali e di posizionamento sul mercato, possiamo dire che sono per il 90% aziende italiane e per il 10% aziende europee. Da 3 anni attraverso la rete europea TESS (di cui siamo soci fondatori) si stanno sperimentando canali di vendita a imprese no-profit in Africa e Centro America e stiamo lavorando affinché tale filiera possa progressivamente crescere da un punto di vista quantitativo.
D: Che posizione avete riguardo la vicenda che ha coinvolto la Nuova Tessil Pezzame sas? Vesti Solidali era a conoscenza di queste inchieste e del fatto che una parte dei vestiti raccolti finivano in quel giro?
R: L’arresto del titolare della Nuova Tessil Pezzame ci ha profondamente inquietato, poiché l’azienda era una dei nostri acquirenti e la sua condotta nella vicenda “L’Africa nel Cuore”, per come appare dalle ricostruzioni giornalistiche, è del tutto incompatibile con le finalità della Vesti Solidale. Per questa ragione, non appena abbiamo ricevuto la notizia dai media, la Rete R.I.U.S.E di cui la Vesti Soldale fa parte ha interrotto immediatamente ogni rapporto con l’azienda, sebbene ovviamente le cooperative della rete R.I.U.S.E fossero del tutto estranea ai fatti contestati. La decisione assunta ha comportato per le cooperative un danno economico. Ma non abbiamo esitato a sostenerlo pur di eliminare anche il minimo dubbio sulla correttezza del nostro operato. Vorremmo far osservare che la Nuova Tessil Pezzame era in possesso di un’autorizzazione in procedura ordinaria per lo stoccaggio ed il trattamento degli indumenti usati rilasciata dalle autorità competenti cui spetta il controllo di effettuare le verifiche. Per dovere di cronaca va anche detto che a quanto ci risulta alla data attuale il processo è ancora in corso e si è in attesa della sentenza di primo grado.
D: E cosa sapete dirci invece dei rapporti intercorsi con l’azienda T.?
R: La Rete R.I.U.S.E ha venduto indumenti usati alla società T. sino al 2018. Fino a quel momento era la società leader del mercato italiano e commercializzava indumenti usati raccolti in diverse regioni italiane. Inoltre la società era in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e poteva svolgere pienamente quelle attività. Difficile sospettare che una realtà così affermata non fosse sottoposta al controllo degli enti preposti e potesse assumere condotte non conformi alle norme. In ogni caso, una volta conclusosi il primo grado di giudizio con la condanna dei soci, la Rete R.I.U.S.E ha ritenuto cautelativamente di NON avere ulteriori rapporti commerciali con la T. SpA. Vogliamo sottolineare che questa decisione è stata assunta, nonostante la stessa società potesse continuare ad operare in piena legalità. Anche in questo caso, come per la Nuova Tessil Pezzame, le cooperative della rete R.I.U.S.E non hanno avuto alcuna esitazione nell’adottare una linea di condotta più severa di quella che il semplice rispetto delle leggi avrebbe richiesto. Ci teniamo che sia fatta assoluta chiarezza sul fatto che né T. né Nuova Tessil Pessame e nessun altro acquirente utilizzato dalla rete R.I.U.S.E è stato condannato o accusato di far parte della criminalità organizzata o di riciclare denaro del narcotraffico. Per quanto attiene al logo di T. presente sui cassonetti della rete R.I.U.S.E fino al 2018, è bene precisare che il logo in realtà era del consorzio Conau (a cui sia la rete R.I.U.S.E che T. aderivano) con indicazione del partner commerciale principale in quel momento (T. appunto) a cui era destinato circa il 50% del materiale raccolto.
D: Ad oggi, come Rete R.I.U.S.E, quali criteri utilizzate per scegliere i vostri acquirenti e quali marchi di garanzia adottate?
R: Chiediamo agli acquirenti documentazione che va ben oltre quella normalmente in uso negli scambi commerciali tradizionali proprio a tutela della nostra reputazione. Per quanto riguarda le garanzie sui soggetti che acquisiscono i vestiti facciamo osservare che ciascun acquirente, poiché è stato autorizzato dalle autorità competenti ad operare secondo le norme di legge vigenti, è sottoposto ai controlli da parte delle autorità preposte. Da tempo chiediamo al legislatore che sia istituito un Albo degli impianti autorizzati sotto controllo pubblico. Ciò offrirebbe maggiori tutele sia ai cittadini sia agli operatori onesti del settore ed eviterebbe che qualche concorrente con pochi scrupoli strumentalizzi queste vicende magari per conquistare maggiori quote di mercato.
6. Nuove regole in arrivo: l'attuazione delle direttive sull'economia circolare. cosa cambierà per i tessili?
Ci sono importanti novità in arrivo. Dal 26 settembre 2020 è operativa la disciplina comunitaria sui rifiuti che, in attuazione delle direttive europee (2018/851/Ue e 2018/852/Ue), detta nuove regole in tema di rifiuti. Si tratta di uno dei decreti di attuazione del cosiddetto 'Pacchetto di direttive sulla economia circolare', adottato dall'Unione europea a luglio 2018.
Tra gli obiettivi delle nuove direttive è previsto che i rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi (come vernici, pesticidi, oli e solventi) dovranno essere raccolti separatamente dal 2025. «Nella parte riguardante gli abiti usati, la novità più significativa è rappresentata dalla previsione dell’obbligatorietà della raccolta separata dei tessili», conferma Roberto Cavallo, AD di Erica Soc. Coop, attiva nel campo della riduzione dei rifiuti, e vicepresidente del Comitato Scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Piano Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti del MATTM in carica fino al 2017.
Prima del recepimento della normativa europea, i comuni italiani non avevano nessun obbligo al riguardo e potevano esimersi dall'effettuazione della raccolta differenziata dei tessili. Ora non è più così. Il decreto legislativo dispone che, entro il 2025, la raccolta differenziata della frazione tessile dei rifiuti urbani, oggi su base volontaria, diventi obbligatoria. Con il decreto attuativo, l'Italia ha deciso di imporsi una scadenza anticipata, il 1° gennaio 2022.

Un abito di seconda mano ha tre possibilità di rinascita nel momento in cui l'utente originario decide di disfarsene.
- La prima opzione è la rivendita (reselling). Ciò significa che, attraverso un sistema di raccolta e selezione, l'indumento viene finalizzato a una vendita. Rientra dunque nel mercato commerciale come bene.
- La seconda opzione è il riuso ed è quella che meglio ricalca l'aspetto caritatevole. L'utente decide di donare il proprio indumento usato a persone meno abbienti.
- Infine c'è l'opzione del riciclo, sulla quale l'Italia presenta un enorme vulnus, non avendo mai sviluppato una vera e propria filiera del riciclo, né sui tessili né sulle altre tipologie di rifiuti. Gli indumenti gettati nei cassonetti vengono infatti selezionati: la cosiddetta crema, i prodotti di qualità migliore, rimane in Italia ed entra nel circuito del reselling e del riuso. La stragrande maggioranza, non avendo nessun valore economico per il mercato italiano, viene invece esportata all'estero, in paesi in via di sviluppo, dove alimenterà a sua volta un mercato di seconda mano. L'ulteriore parte rimanente, lo scarto dello scarto, viene finalizzata allo smaltimento.
7. Classificazioni dei tessili: ambiguità
È sul tema della classificazione che i rifiuti tessili rimangono in un limbo. Il decreto introduce la decisione di considerare come rifiuti urbani anche quelli derivanti da raccolta indifferenziata provenienti da utenze non domestiche ma che sono «simili per natura e composizione» ai rifiuti domestici. Questo significa che con la nuova norma, molti rifiuti da speciali diventano urbani per legge. «I rifiuti tessili provenienti dalle operazioni di selezione delle raccolte effettuate da aziende specializzate nella successiva vendita erano e rimangono rifiuti speciali», precisa Cavallo. «Il fatto che gli scarti tessili prodotti dalle aziende specializzate nella compravendita di abiti usati non rientrino nella nuova definizione di rifiuti urbani, potrebbe dunque sembrare una prima contraddizione (o ambiguità) della normativa italiana, dal momento che si tratta di attività che ogni anno producono diverse tonnellate di rifiuti tessili, spesso, peraltro, smaltite illegalmente. Nei prossimi mesi occorrerà però definire con maggiore chiarezza cosa classificare esattamente sotto il cappello dei 'rifiuti tessili'».
8. La norma italiana: manca qualcosa?
Secondo Cavallo, ci sono però una serie di potenziali criticità. La nuova norma introduce in Italia il principio di Responsabilità Estesa del Produttore (ERP), un principio che rafforza l'interesse diretto dell'azienda produttrice non solo del rifiuto, ma anche del bene che diventerà il rifiuto. Secondo tale principio, l'inquinamento ha un costo che deve essere sostenuto dal soggetto che produce il bene inquinante. Per i tessili significherà immettere sul mercato prodotti più durevoli, riutilizzabili, facilmente separabili e riciclabili. Se da una parte questa novità sembra un ottimo traguardo, allo stesso tempo pone il mondo delle cooperative sociali di fronte a un rischio. «Il rischio è che le grandi aziende che producono abbigliamento e tessili, possano associarsi in enormi consorzi, tagliando fuori dal mondo della raccolta tutte le cooperative sociali, che non sarebbero in grado di concorrere contro questi enormi associazioni», spiega Cavallo. «L'iniziativa, seppur buona in principio, potrebbe dunque mettere a rischio migliaia di posti di lavoro».
Il sistema di raccolta dei rifiuti in Italia potrebbe inoltre non reggere l'incremento di quantità di 'nuovi' rifiuti urbani derivante dall'assimilazione 'forzosa' dei rifiuti speciali a quelli urbani, un elemento che potrebbe creare problemi ai piani di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni e delle Regioni.
«A mio avviso, il sistema in parte è pronto e in parte deve attrezzarsi», afferma Cavallo. «In particolare, mancano alcuni impianti delle filiere di riciclo, penso ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), agli Pneumatici Fuori Uso (PFU), alle plastiche e appunto ai tessili. In alcuni casi occorre riequilibrare la dotazione impiantistica tra aree geografiche del Paese, in particolare occorre costruire impianti di compostaggio nelle regioni del sud, anche per rispettare il principio di prossimità, troppo spesso disatteso».
9. Buone pratiche: il caso di humana people to people e del comune di albano laziale
«L’importante è garantire la trasparenza della filiera - afferma Karin Bolin, Presidente di HUMANA People to People Italia, l’organizzazione umanitaria leader nella valorizzazione dei capi usati - Il nostro servizio di raccolta di abiti usati è realizzato in conto proprio con automezzi di nostra proprietà e personale dipendente. Questo permette un livello di controllo interno tale che le infiltrazioni non sono neanche immaginabili».
In Italia, i cassonetti con il logo di HUMANA sono presenti in 1.148 comuni. E grazie a più di 5.600 contenitori stradali dislocati in 43 province, il servizio qualificato di HUMANA raggiunge gratuitamente più di 19,5 milioni di cittadini.
«La raccolta è realizzata a titolo gratuito per le Amministrazioni comunali convenzionate - continua Bolin - Raccogliamo abiti grazie all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 1 classe A e li conferiamo nei nostri impianti in Italia. Nella fase di smistamento, possiamo utilizzare anche tutte le nostre sedi della rete di Humana: e quindi smistare in Italia o negli altri Paesi in cui siamo presenti. Grazie alla raccolta differenziata e al recupero di abiti usati, sosteniamo progetti di cooperazione internazionale di lunga durata nel Sud del mondo e progetti socio-ambientali in Italia, gestiti direttamente da noi con le risorse prodotte dalla nostra filiera». Investire nel reparto smistamento, aumentando anche il numero di persone assunte e migliorando il metodo di selezione, conferisce maggiore controllo della filiera.
Nel 2019, HUMANA ha raccolto circa 27mila tonnellate di abiti. Quelli che non possono essere rivenduti come vestiario nei negozi di Humana, vengono riciclati per recuperare le fibre, garantendo la sostenibilità ambientale, e solo una piccola parte, troppo usurata o malconcia, è destinata al recupero energetico. «Alcuni dei vestiti che non vendiamo in Italia o in Europa, vengono inviati in Africa - spiega Bolin - ai progetti locali che sosteniamo, che possono rivenderli a loro volta. Questo crea un ciclo virtuoso: gli abiti diventano occupazione, creando posti di lavoro e un business pulito con scopo sociale, che permette di valorizzare il capo donato».
HUMANA, però, non è presente su Roma. Non ha partecipato alla gara indetta dal Comune. Un episodio del 2019 ha forse lasciato il segno: tre furgoni utilizzati per il trasporto di abiti usati destinati alla Capitale avevano preso fuoco a Pomezia. I Carabinieri non avevano avuto dubbi sulla matrice dolosa dell’incendio.
«I nostri sforzi sono volti a comunicare costantemente con chiarezza l’intera filiera, a partire dalla sua spiegazione sui nostri contenitori in un’ottica di massima trasparenza», conclude Bolin.


Ad Albano Laziale, un comune a sud di Roma di circa 40mila abitanti, HUMANA People to People ha iniziato a prestare il servizio di raccolta degli indumenti usati nel 2013. Un anno non positivo per le cooperative: era appena scoppiato lo scandalo di Mafia Capitale. Un rapporto steso dal Ministero Olandese delle Infrastrutture e della Gestione delle Risorse Idriche nell’ambito dell’ECAP (European Clothing Action Plan), il primo progetto dell’UE sulla sostenibilità della raccolta dei capi di abbigliamento, ha indicato Albano come esempio virtuoso nel riuso degli indumenti.
Luca Andreassi, consigliere comunale di Albano Laziale con delega alla gestione dei rifiuti, racconta la storia di HUMANA nel territorio come una storia di successo, di buone pratiche, di relazione continua con la cittadinanza.
«Albano Laziale è passata in 3 anni da una raccolta di abiti usati di circa 1 kg/anno procapite a quasi 5,5 kg/anno procapite diventando il secondo Comune in Italia tra quelli serviti da HUMANA per quantità assoluta di abiti usati – racconta Andreassi – Ma non è solo un fatto di numeri. Il punto essenziale è il coinvolgimento della cittadinanza. HUMANA, ogni anno, mette a disposizione una cifra simbolica per buoni acquisto di libri che vengono erogati a tutti i ragazzi delle terze medie che escono con buoni voti. Idealmente, il ragazzo di 13 anni di Albano è legato con un fil rouge al ragazzo di uno dei paesi dell’Africa subsahariana in cui HUMANA opera».
10. La porta d'ingresso per l'Africa

Che fine fanno questi vestiti? Una volta gettati nei cassonetti, raccolti dalle cooperative sociali e comprati dalle aziende private, dove finiscono? La stragrande maggioranza di questi indumenti viene venduta all’estero dalle aziende private che li hanno acquistati. La principale destinazione dell’export italiano è Tunisi. E da Tunisi, poi, si apre l’ingresso per l’Africa Orientale, terra di vendita e di scontro di più potenze internazionali.
11. Dal vesuvio al kilimanjaro
Il mercato di abiti usati di Moshi, nel nord della Tanzania, appena sotto le pendici del Kilimanjaro, è un dedalo di stradine affollate e banchetti di vestiti usati. Ad ogni ora, arrivano camion pieni di balle di indumenti provenienti dai mercati di Dar es Salaam e destinati ad essere selezionati per qualità nei piccoli magazzini che contornano le bancarelle. Moshi vanta uno dei centri di smistamento e vendita più grandi della Tanzania, subito dopo il mercato di Manzese, a Dar es Salaam. Big Mama è una delle tante grossiste che aspettano freneticamente l’arrivo dei camion. Come una manager, dirige i suoi sottoposti, fa suddividere le balle per tipologia di vestiti, e aspetta che arrivino i commercianti al dettaglio per l’acquisto.
Da questo momento in poi, i vestiti usati smettono di chiamarsi così. Il nome utilizzato è Mitumba, che in kiswahili significa “seconda mano” ma, in Africa Orientale, ha preso il significato di “vestiti provenienti dai paesi occidentali”. Un termine che lega il Vesuvio al Kilimanjaro e disegna la geografia del settore più globalizzato per eccellenza: dal trasporto allo stoccaggio, i mitumba girano il mondo più di tutte le altre merci. Il commercio di mitumba è cresciuto esponenzialmente negli ultimi dieci anni. Secondo lo UN Comtrade, il database delle statistiche sul commercio delle materie prime delle Nazioni Unite, le esportazioni mondiali hanno raggiunto i 4,8 miliardi di dollari e solo l’Africa orientale ha importato vestiti e scarpe usati per un valore di 151 milioni di dollari.
Big Mama acquista le balle senza poterne vedere il contenuto. Più alta è la qualità, più il costo sarà elevato. Una balla di 45 chili può arrivare a costare 600mila scellini tanzaniani, ovvero circa 220 euro. La qualità della balla è decisa a monte, a seconda dell’imballaggio e della provenienza. Big Mama non ha scelta, così come il commerciante al dettaglio che la acquisterà da lei: o prendere o lasciare. Non è possibile sapere quanti e quali vestiti contiene, e se saranno tutti utilizzabili. Ad ogni modo, un dato è certo: Big Mama offre lavoro ad oltre 50 persone, tra selezionatori, distributori e chi disfa le balle. Un numero di gran lunga maggiore rispetto ai lavoratori impiegati in qualsiasi fabbrica tessile locale. Il lavoro delle balle alla cieca conviene a tutti.

La pandemia da Covid-19 non ha modificato questa catena di montaggio. La Tanzania è uno dei paesi meno sviluppati al mondo – occupa il 151° posto su 188, secondo le Nazioni Unite – con dei livelli di povertà molto elevati: l’indice multidimensionale di povertà (MPI) evidenzia che il 64% della popolazione in Tanzania continentale vive in povertà e il 31,3% in estrema povertà. L’impatto del Covid sull’economia del Paese è stato importante, ma non quanto si immagina. Il Presidente della Tanzania, John Magufuli, al potere dal 2015, ha dichiarato il Covid sconfitto ad aprile 2020, riaprendo il Paese al turismo – l’unico in tutta l’Africa orientale – smettendo di effettuare tamponi o test sierologici e di inviare report al Ministero della salute e all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo ha determinato una lieve crescita economica, che ha fatto balzare la Tanzania nelle classifiche di reddito trasformandola da paese a reddito basso a paese a reddito medio, secondo la World Bank.
Un dato rilevante anche per l’economia di mitumba che, grazie a questo meccanismo, ha subito poche perdite. D’altronde, basti pensare che i mitumba costituiscono la prima voce di importazione e il 90% della popolazione si veste di seconda mano. Un settore che, secondo il Ministero del commercio della Tanzania, colma il vuoto che lascia il settore tessile locale, non ancora in grado di soddisfare la domanda di vestiti. È una filiera che dà lavoro a milioni di persone. E porta reddito al governo, che recupera da questo commercio il 25% di tasse sull’importazione e il 20% di IVA sui prodotti. In tutta l’Africa, fino al 30% del lavoro informale (volgarmente detto “lavoro nero”) ruota intorno al commercio di abiti usati.
Secondo un rapporto dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale USAid, solo nell’Africa orientale il mercato dell’usato raggiunge i 230 milioni di dollari di profitti per un totale di 355mila posti di lavoro. Oggi il continente importa prodotti dall’esterno anche se presenti al suo interno, a causa sia delle difficoltà di stoccaggio e di spostamento, sia delle frontiere e delle dogane infra-africane. Le barriere commerciali tra Paesi africani sono oggi del 6% più alte rispetto a quelle tra quest’ultimi e resto del mondo. Dal 1 luglio del 2020, dopo anni di negoziati, sarebbe dovuta entrare in vigore un’area di libero scambio africana (AfCFTA). L’intesa si concentrava sulla riduzione delle tariffe commerciali che precludono lo sviluppo del commercio intra-africano, ancora oggi una quota minoritaria – intorno al 19% – degli scambi commerciali degli Stati africani. Però, qualcosa non ha funzionato. L’avvio dell’operatività dell’Area di libero scambio continentale africana è stato spostato al 1° gennaio 2021 dall’Assemblea dei capi di Stato dell’Unione africana. Ancora un anno intero prima che l’Africa possa accelerare l’integrazione e i processi di industrializzazione.
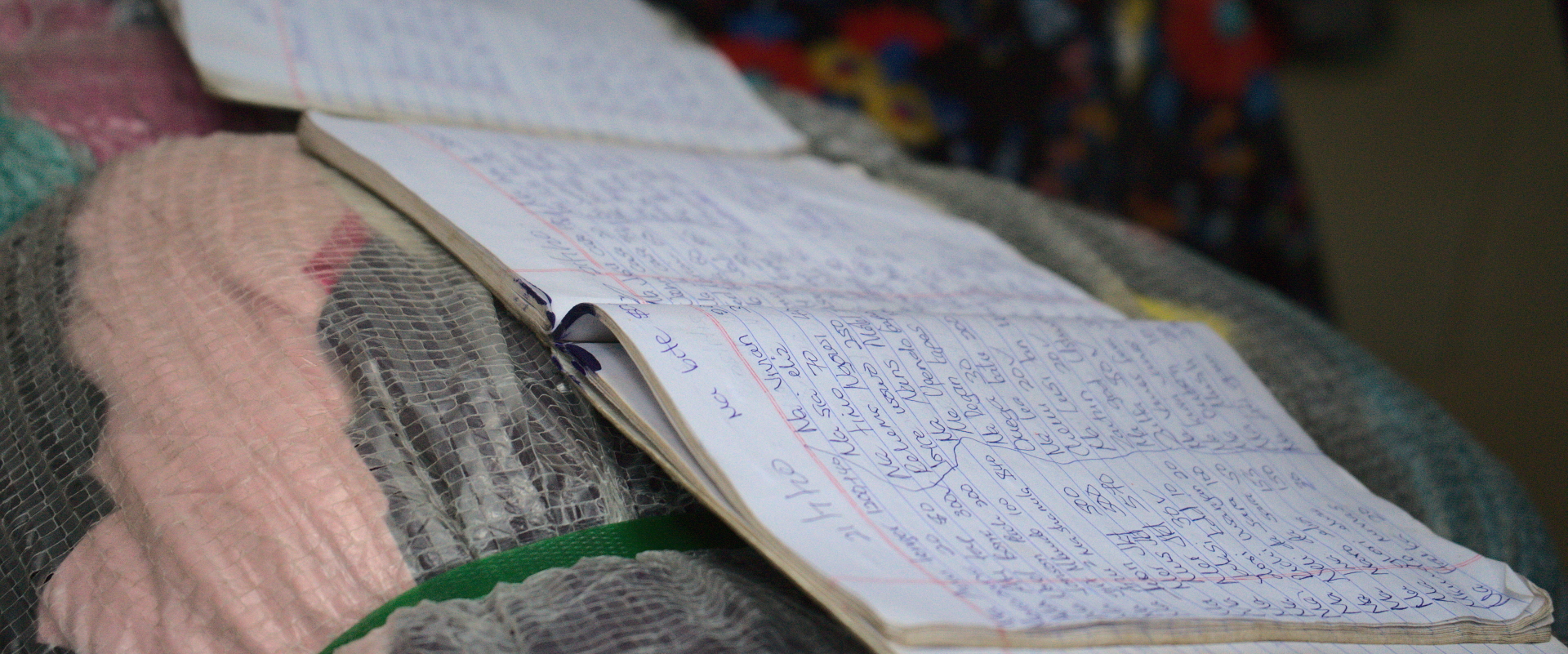
12. Diritti umani, donne e lavoro

«Comprare le balle che contengono vestiti da donna conviene, c’è più possibilità di trovare capi in buono stato. Gli uomini usano le cose di più, e quindi arrivano in condizioni peggiori», racconta mettendo a posto magliette e pantaloni. Jennifer ha una famiglia sulle spalle e lavora con i mitumba da oltre dodici anni. Dodici ore di lavoro al giorno, come Edrina e le altre che hanno banchi una accanto all’altra. Alcuni sarti rammendano le toppe, altri puliscono le macchie, adattando così i vestiti occidentali al corpo dei tanzaniani. Non esistono orari, contratti o dinamiche del lavoro da rispettare: si tratta di lavoro informale, sottopagato, a largo impiego di donne. Arrivare a fine giornata con le mani stanche è all’ordine del giorno. Ognuno è imprenditore di sé stesso, ognuno acquista e vende a proprio rischio. E per portare a casa qualcosa, bisogna lavorare di più e lavorare meglio degli altri, in un regime di competitività al massimo ribasso.



13. Il più grande esportatore di Mitumba: gli Stati Uniti

Non solo l’Italia. Camminando per l’affollata Morogoro road, i marchi statunitensi sono i primi ad essere esposti. Secondo le stime dell’East African Community (EAC), l’organizzazione regionale intergovernativa composta da sei stati partner (Burundi, Kenya, Rwanda, Sud Sudan, Tanzania e Uganda), il commercio di mitumba proveniente dagli USA aumenta talmente tanto di anno in anno che le imprese americane coinvolte nell’export riescono ad aumentare del 60% il proprio fatturato annuo. È un commercio così importante e sentito da indurre le imprese a formare associazioni di categoria che da decenni si occupano di riciclo, rimessa in vita e diffusione di materiale usato. Tra queste, la più importante è la Secondary Materials and Recycled Textiles (SMART), che riunisce 40 realtà imprenditoriali (per la maggior parte statunitensi, ma non solo), accomunate dall’attività di riciclo e riuso di materiali tessili e di export all’estero di abiti usati.
Il sistema della raccolta negli Stati Uniti non è tanto diverso da quello che si ha in Italia o in altri paesi europei. I cassonetti sono distribuiti sul territorio nazionale, spesso con i loghi di alcune charities. Il contenuto dei cassonetti è acquistato in molti casi proprio dai componenti della SMART, che si occupano, tra le varie cose, di compravendita di abiti usati. Insomma, acquistano dalle charities ed esportano all’estero. Oppure, vendono ai grandi rivenditori nazionali di abiti di seconda mano. Il sistema, in alcuni casi, ha una struttura ad “integrazione verticale”, il che vuol dire che raccoglitori ed esportatori coincidono. È il caso di Salvation Army, un movimento evangelico internazionale fondato a Londra nel 1865 ma presente anche in Nord America e che si occupa, tra le varie cose, di raccolta e vendita di abiti usati. In questi casi il margine di guadagno è molto ampio perché si elimina la transazione della compravendita tra charity e imprenditore che esporta.
14. Il veto agli abiti di seconda mano: "america first" e africa last?
Il quartier generale della East African Community (EAC) è adiacente al centro di Arusha, la città che per i turisti è la capitale dei safari della Tanzania. L’EAC è il luogo dove i Capi di stato dei sei stati partner si riuniscono per i Summit economici durante i quali discutono del futuro delle proprie economie e dell’imprenditoria locale. La sorveglianza è massima ed è vietato fotografare o riprendere l’entrata. Nonostante gli sforzi, ottenere un’intervista a tema mitumba si rivela più difficile del previsto. I funzionari dell'organizzazione, dopo aver acconsentito ad un incontro, si tirano indietro. “Qualcosa ci rende sospettosi”, scrivono.
Fatto sta che l’EAC è sotto gli occhi dei riflettori - statunitensi, soprattutto - dal 2016, anno in cui l’organizzazione decise di adottare tasse aggiuntive sugli indumenti usati di importazione. L’obiettivo era chiaro: favorire l’industria tessile locale e arrivare, entro il 2019, a bandire completamente il commercio di mitumba. Secondo un comunicato stampa dell’EAC, durante un Summit dei Capi di stato, i leader hanno dichiarato: «Il tessile, la lavorazione del pollame e la produzione automobilistica sono i settori che vanno incentivati per lo sviluppo industriale e per la creazione di posti di lavoro della regione. Per farlo, è necessario eliminare l'importazione dall'estero di merci e prodotti usati. Siamo desiderosi di incentivare industrie verticalmente integrate nel settore tessile».
Uganda, Rwanda e Tanzania furono i capofila di questo tentativo di risveglio, fortemente voluto dagli imprenditori tessili locali. Tuttavia, questa strategia volta alla tutela dei prodotti e della merce locale poco si concordava con l’agenda conservatrice delle potenze internazionali interessate al commercio.
E allora la SMART iniziò a scatenare una guerra commerciale: a rischio c’erano 40mila posti di lavoro nel settore privato, 150mila nel terzo settore e un mercato da 1 miliardo di dollari l’anno per le industrie USA specializzate, le quali si sarebbero viste diminuire il fatturato del 70%.

Il 2016 è stato anche l’anno dell’elezione di Donald Trump a 45° presidente degli Stati Uniti, e, sfruttando la volontà della nuova amministrazione di far emergere la posizione di forza nel settore del commercio internazionale, la SMART decise di cogliere l’opportunità.
Dopo l’aumento delle tariffe da parte dell’EAC, l’associazione esercitò pressioni sui funzionari del governo canadese e statunitense per far sì che alcune politiche convincessero i paesi promotori del bando a fare marcia indietro. Ecco come.

Nel marzo 2017, la SMART presentò una petizione al Rappresentante commerciale degli Stati Uniti (US Trade Representative – USTR) per chiedere una revisione degli accordi commerciali con i paesi dell’EAC. In breve: la SMART volle sapere con estrema precisione se i paesi promotori del bando – Rwanda, Uganda e Tanzania – portando avanti quel tipo di richiesta, avrebbero continuato a soddisfare i criteri di idoneità sanciti dal cosiddetto AGOA, ovvero l’African Growth and Opportunity Act, un accordo commerciale preferenziale tra Stati Uniti e alcuni paesi dell’Africa subsahariana, che consente dazi ridotti o nulli su circa 6.500 tipi di merci esportate in America da 38 Paesi dell’Africa. Un tipo di pressione economica basata su un concetto semplice: l’Africa orientale aumenta le tariffe, le associazioni di categoria statunitensi rispondono minacciando di aumentare i dazi su tutti i prodotti facenti parte dell’accordo.
«Il punto è molto semplice, l’AGOA è stato firmato da entrambe le parti – afferma Jackie King, Executive Director della SMART – E uno degli obblighi previsti dall’accordo è quello di eliminare le barriere al commercio e agli investimenti statunitensi. Il divieto all’importazione di abbigliamento di seconda mano contraddice chiaramente il requisito.»
Certo è che porre un divieto di importazione non era cosa semplice per i paesi dell’Africa orientale. Non solo le pressioni delle associazioni di categoria, ma anche il mercato interno non si fece trovare pronto. In Tanzania, decine di migliaia di lavoratori del settore informale e le loro famiglie dipendevano dal commercio di indumenti di seconda mano, già sofferenti per il calo delle importazioni dovuto all’aumento delle tariffe nel 2016.
Le pressioni fanno paura, ma le perdite economiche e di benefici ancora di più.

Un funzionario statunitense, all’epoca dei fatti osservatore del procedimento in seno allo USTR, è convinto che le ritorsioni per i paesi africani coinvolti sarebbero state eccessive. «In quei mesi fornivo informalmente consulenza al governo del Kenya – ha dichiarato durante un’intervista in cui ha preferito mantenere l’anonimato – Ricordo di aver suggerito ai funzionari governativi di sottostare alle pressioni di Washington e di puntare a un compromesso, perché in alternativa le conseguenze e le sanzioni sarebbero risultate disastrose.» I paesi dell’EAC, compresa la Tanzania, di fatto non disponevano di una base di produzione di indumenti interna sufficiente a soddisfare le esigenze del mercato con la sola produzione locale o regionale. Pertanto le importazioni a basso costo da paesi come gli Stati Uniti avevano la funzione di colmare il divario tra mercato interno e la domanda. La potenziale minaccia di deprivazione sociale ed economica che si sarebbe verificata se fossero stati del tutto esclusi dall’AGOA era troppo grande da fronteggiare.
Insomma, esistono validi motivi per pensare che in realtà Washington abbia utilizzato l’AGOA anche per controllare quelli che dovrebbero essere degli alleati economici. Ad esempio, Paul Ryberg, avvocato di base a Washington, esperto di commercio internazionale e presidente della African Coalition of Trade (ACT), un’associazione di categoria senza scopo di lucro di società e associazioni africane impegnate nel commercio con gli Stati Uniti nell’ambito dell’AGOA, ne è convinto. «I dazi non violavano i termini dell’AGOA – racconta Ryberg – Gli indumenti in questione, nella maggior parte dei casi erano stati prodotti al di fuori degli Stati Uniti e quindi non potevano qualificarsi come export statunitense. Per poter essere considerati export targato USA, avrebbero dovuto quantomeno subire una certa lavorazione negli Stati Uniti, cosa che non è accaduta.»
I paesi dell’EAC, nel febbraio del 2018 annunciarono che gli stati partner si sarebbero concentrati sulla costruzione del settore tessile interno in un modo tale da non mettere a repentaglio l’AGOA.
Quel sogno di libertà che avrebbero voluto raggiungere dal 2019 non si è mai avverato. E questo è valso per tutti, tranne che per uno: il Rwanda.

I ricatti delle associazioni di categoria non hanno funzionato per tutti. Il governo ruandese, sotto la guida di Paul Kagame, non ha fatto passi indietro. «Si tratta di scegliere, - ha affermato Kagame - scegliamo di ricevere vestiti di seconda mano sotto la minaccia dell'AGOA, o di far crescere l'industria tessile che i ruandesi meritano?». A differenza dei paesi limitrofi coinvolti, questa affermazione il Rwanda può permettersela: secondo il ministro delle Finanze Uzziel Ndagijimana, negli ultimi 18 anni il Pil del paese è quadruplicato, la crescita annua media è dell’8%, e il reddito pro capite moltiplicato per 3,5. Secondo i dati governativi, dal 2000 al 2018 la popolazione sotto la soglia di povertà è passata dal 60 al 38%, mentre l’aspettativa di vita è passata da 49 a 67 anni. Insomma, il Rwanda vanta un’autosufficienza dalle potenze occidentali dell’84% di tutto il suo prodotto interno e non ha paura di ritorsioni o ricatti economici. Nel 2016, importava l’equivalente di 15 milioni di dollari in vestiti di seconda mano. Da quell’anno, ha iniziato ad alzare le tariffe sull’importazione di indumenti usati portandole da 0,20 dollari a 2,50 dollari al kg. Nessuna Big Mama si sarebbe potuta permettere quei prezzi e questo avrebbe causato gradualmente l’eliminazione dal commercio dei mitumba. Kigali voleva promuovere l'abbigliamento "made in Rwanda” per colmare il deficit commerciale, riducendo le importazioni di beni che possono essere prodotti localmente quali scarpe e vestiti. Da quel momento, l'importazione di vestiti di seconda mano è diminuita di un terzo. E però le difficoltà si vedono. La perdita più grossa riguarda i posti di lavoro: l’industria dell’abbigliamento locale ne crea 25 mila, quella dei mitumba ne creava oltre 300 mila, considerata tutta la filiera di distribuzione.
Ma ciò che conta davvero per i ruandesi è l’idea costruttiva, la resistenza di questo piccolo paese senza sbocco sul mare che potrebbe essere la risposta e il terreno di prova alla domanda se l'Africa possa fare a meno dell’economia degli stracci. E, soprattutto, se sia possibile sopravvivere senza accordi commerciali con gli Stati Uniti e con l’Occidente.
15. «È come un casinò e il banco vince sempre»: l'occidente vince e la big mama perde

Secondo le stime raccolte da Let’s Recycle, canale di informazioni e analisi sul tema del riciclo e del riuso nel Regno Unito, tra aprile e maggio 2020, il prezzo stimato per balla di vestiti da 45 kg, pagato da chi opera nella compravendita di abiti usati nel paese, è improvvisamente crollato ad un valore compreso tra i zero e i tre dollari a balla (dai $16 riportati in precedenza).
I motivi potrebbero essere molteplici. In primis, l’arrivo nello scenario globale della pandemia da Covid-19. Alcuni paesi africani hanno nuovamente introdotto delle piccole limitazioni all’importazione dei mitumba per la paura che potessero essere veicolo di contagio. Non solo: le chiusure generalizzate degli impianti di stoccaggio e igienizzazione a causa delle misure restrittive anti-Covid-19 hanno posto un ulteriore freno al mercato. Tutto ciò ha provocato un crollo della domanda, causando un conseguente crollo del valore dei vestiti raccolti. Ed ecco spiegato il prezzo.
Ma qualcosa non torna. E per capirlo, bisogna ripensare alla grossista dal nome Big Mama e alle sue balle da 45kg pagate fino a 600mila scellini tanzaniani (258 dollari, o 220 euro). Se si prende a riferimento il valore finale di una balla in occidente, (nell’aprile-maggio 2020, un valore tra i 47 e i 50 dollari) comprensivo anche dei costi di imballaggio e spedizione, secondo i dati di Let’s Recycle, il margine di guadagno per gli esportatori di abiti usati può arrivare fino a 208 dollari per singola balla di vestiti.
«I commercianti africani, siano essi i grossisti o al dettaglio, stanno operando in un mercato con prezzi molto alti, mentre in Occidente i prezzi si sono improvvisamente abbassati» dichiara Kate Bahen di Charity Intelligence, ente indipendente canadese che si occupa del monitoraggio delle charities. Chi opera in questo business di compravendita di abiti usati ha avuto dunque l’occasione per far crescere in pochi mesi i propri guadagni in maniera esponenziale. Le charities hanno dovuto vendere a prezzi stracciati per la mancanza di domanda, ma gli esportatori hanno continuato a vendere ai paesi africani a prezzi alti, rendendo il margine di guadagno a dir poco elevato.
«È come un casinò. Grossisti e commercianti in Tanzania scommetteranno con un ‘all-in’, mentre il banco – in questi casi rappresentato dagli esportatori occidentali – vince sempre», conclude Bahen.
16. Le produzioni locali: è possibile farcela da soli?
Cedere alle pressioni occidentali ha significato molto per la Tanzania. Vedere il vicino Rwanda pronto a spiccare il volo, ha causato non poche domande per i cittadini di Dar es Salaam e di Moshi. Ma l’economia legata ai mitumba fa parte della cultura quotidiana da metà degli anni ‘80, intere famiglie sfamano i propri figli con i ricavi di indumenti usati. L’obiettivo di vietare le importazioni entro il 2019 non era attuabile per la Tanzania. La fast fashion non ha aiutato il processo: molta attenzione alla durata dell’indumento e poca alla qualità, tanto da renderlo economico fino al punto dell’usa e getta. Tonnellate di capi di abbigliamento arrivano proprio dai marchi economici di utilizzo comune – H&M, Zara, Gap etc – e, con una riduzione così drastica del tempo medio di utilizzo, si capisce come siano tutti indumenti che finiranno nelle balle gestite da Big Mama.


17. L'impatto ambientale
Accanto a quei tredici capannoni, disposti in fila indiana all’ombra del Vesuvio, si respira un odore acre di abbandono. Gli indumenti usati che fuoriescono dalle fessure, piene fino a scoppiare, sembrano gli stessi che riempiono le discariche dislocate per tutta l’Africa orientale. L’impatto ambientale dell’invenduto e dell’invendibile è drammatico e le migliaia di tonnellate di rifiuti generati sono altamente tossici. Gli indumenti portano targhe di marche conosciute: H&M, Zara, Gap, sono solo alcuni tra i nomi più visibili.
In generale, l’industria della moda è capace di muovere da sola più di 2,5 migliaia di miliardi di dollari in tutto il mondo, una cifra pari al PIL della Francia. L’avvento della fast fashion - i vestiti a basso costo - ha mostrato quanto velocemente potesse sparire l’idea di un consumo consapevole, grazie ai prezzi sempre più bassi del ready to wear (o prêt-à-porter) e degli stock che riprendono i grandi marchi, oggetti sempre più inclini ad usurarsi presto. Il concetto è semplice: mentre la moda tradizionale offre due collezioni l'anno, la fast fashion può arrivare a portare sul mercato fino a cinquanta serie diverse nello stesso lasso di tempo. L'impulso all'acquisto viene così costantemente alimentato e favorito dall'economicità del prodotto offerto.
Dal 1975 al 2018, la produzione è passata da a livello globale. Al fine di velocizzare questo tipo di produzione e di aumentarne sempre di più i consumi, vengono utilizzati materiali come il poliestere, che ogni anno arriva a produrre gas serra pari a quelli rilasciati da 185 centrali elettriche a carbone (oltre 700 Mld di Kg), e il cotone. Quest'ultimo ha bisogno di un'enorme quantità d'acqua per favorirne la coltivazione (20mila litri per kg). La produzione del cotone utilizza circa il 2,5% delle terre arabili del mondo e per la sua coltivazione, oltre all’acqua, sono necessarie enormi quantità di pesticidi e fertilizzanti. Inoltre, per essere lavorato, il cotone richiede più energia delle fibre sintetiche.
Negli ultimi quindici anni, la vita media dell’abito si è ridotta del 36%. Una ricerca dal titolo “The environmental price of fast fashion”, pubblicata su Nature Reviews Earth & Environment, spiega bene come con 4.000-5.000 milioni di tonnellate di CO2 rilasciate annualmente nell'atmosfera, l'industria della moda nella sua globalità (tessile, abbigliamento, accessori, calzature e via dicendo) è responsabile di circa l'8-10% delle emissioni globali. Con 190.000 tonnellate, è colpevole dell'accumulo negli oceani di oltre un terzo delle microplastiche. Contribuisce per il 20% alla contaminazione industriale dell'acqua in tutto il mondo, e produce più di 92.000 tonnellate annue di rifiuti tessili. Tra questi rifiuti tessili, rientrano soprattutto i capi di abbigliamento invenduti, ovvero quegli stessi indumenti accatastati nei capannoni sotto al Vesuvio e al confine tra Tanzania e Kenya, e in altre discariche africane.
Il secondo posto come settore più inquinante al mondo, dopo quello petrolifero, è proprio quello della moda. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, produce più emissioni di gas serra del trasporto aereo e di quello marittimo messi insieme; l’85% dei vestiti prodotti finisce in discarica e solo l’1% viene riciclato, senza contare i circa 80 miliardi di abiti scartati ogni anno per difetti di fabbricazione. Un costo ambientale che non è più sostenibile. Il WWF nel suo rating dell’industria tessile stima che più di metà delle aziende di questo settore non abbia adottato alcun vero progetto green e che il fabbisogno di abbigliamento continuerà a crescere, passando da 62 milioni di tonnellate nel 2015 a 102 milioni nel 2030. Di conseguenza aumenterà l’inquinamento e i rischi per l'ambiente.

«Se fosse ben gestito, il corretto smaltimento dei vestiti di seconda mano potrebbe invece rigenerare intere economie», spiega Elena Mazzoni, attivista ambientale. «Generalmente, l’industria della moda è la meno ecosostenibile in termini di risorse e di sprechi. Gli indumenti usati, invece, riducono l’impatto ambientale limitando le emissioni di CO2 e l’uso di pesticidi e fertilizzanti, riducendo lo spreco di miliardi di litri d’acqua che, invece, è necessario per generare nuovi vestiti. È ora dunque di ripensare il modello. È necessario rallentare i ritmi di produzione, garantire una maggiore qualità dei prodotti, fare in modo che durino più a lungo».
Si stima che con circa 600 chili di indumenti usati ci sarebbe una riduzione di 2250 chili di emissioni di CO2, e si risparmierebbero circa 3,6 miliardi litri di acqua. Chiaramente, come in ogni settore del marketing, è la domanda che tira l’offerta.
«Ciò che forse più conta è che i consumatori cambino le proprie abitudini di consumo», conclude Mazzoni «Il cambiamento è sempre individuale. Così, invece di buttare i nostri vestiti, forse sarebbe meglio informarsi su come riciclarli. Con l’informazione odierna, la ricerca di materiali a basso impatto ambientale è possibile. Anche allungare la vita media dei capi d’abbigliamento, utilizzandoli per un tempo maggiore, aggiustandoli se rovinati o re-inventandoli, è una mossa giusta. Con questa slow fashion si diminuirebbe gradualmente la velocità di creazione e produzione del settore moda, innalzando gli standard di qualità del prodotto, dell’industria e delle condizioni dei lavoratori».
I contenuti di questa pubblicazione e le opinioni espresse sono di esclusiva responsabilità degli autori Martina Di Pirro, Maged Srour e Francesca Ferrara e non rappresentano necessariamente il punto di vista di Mani Tese e AICS che, pertanto, non assumono alcuna responsabilità. La riproduzione dell’inchiesta è effettuata previa autorizzazione degli stessi autori.
